Per lo sciopero dei trasporti che coinvolge il corriere Gls gli ordini effettuati in questi giorni potrebbero subire un ritardo nella consegna.
EBOOK - epub
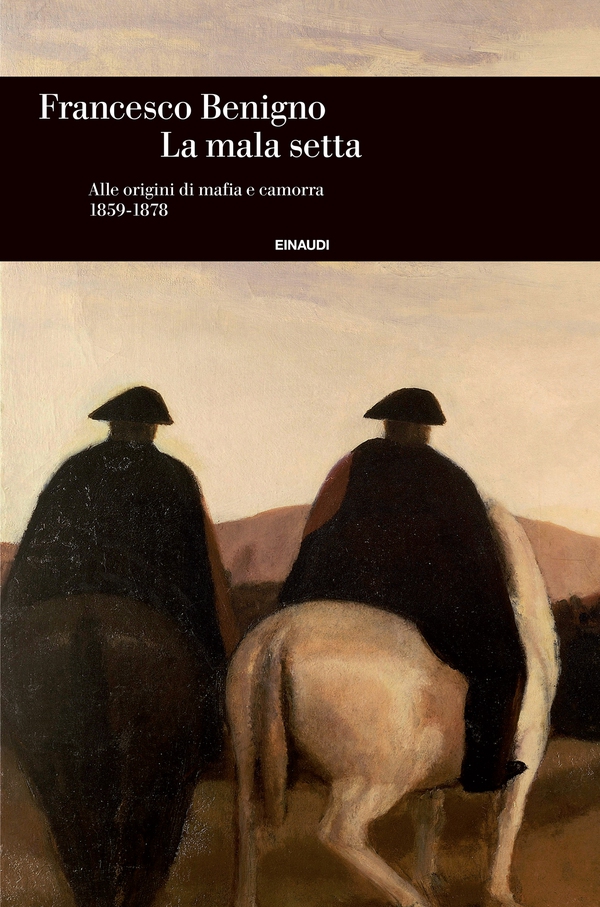
Descrizione
Questo libro si propone di affrontare in modo nuovo la questione del crimine organizzato italiano nella seconda metà del XIX secolo, utilizzando la categoria di «classi pericolose». Questa impostazione è diversa dalla prospettiva, comunemente adottata, che punta viceversa a studiare il crimine organizzato ottocentesco ex post, per cosí dire, «dall'oggi», e cioè a partire dalle forme e dalle strutture che la criminalità organizzata si è data durante il secondo dopoguerra. Vi è al fondo di questa prospettiva un residuo di un pregiudizio di stampo romantico, l'idea per cui vi siano dei soggetti separati, «i criminali», intesi come un popolo a parte, portatore di inequivocabili stigmate comportamentali e attitudinali che li rendono sempre uguali a sé stessi malgrado il tempo trascorso. L'adozione del modello delle «classi pericolose» consente invece di muoversi in direzione opposta, basandosi sulla concezione del crimine condivisa nell'Ottocento. Tutto ciò ha conseguenze importanti. Piuttosto che considerare, ad esempio, l'analisi della mafia delle origini come una sorta di premessa utile a sceverare le radici lunghe di pratiche criminali che daranno poi luogo nel XX secolo a «Cosa nostra», esso invita invece a immergersi nella confusione dei discorsi e delle pratiche di quell'epoca. Inoltre, una prospettiva del genere obbliga a riunire ciò che è stato artificialmente separato, vale a dire l'indagine sulla camorra a quella sulla mafia. Vi è infine il bisogno di uscire da una certa concezione ristretta della storia del crimine come storia sociale intesa alla vecchia maniera, reintroducendovi le urgenze della politica e le forme dell'immaginario collettivo.
Lo sviluppo del crimine organizzato nei primi due decenni dell'Italia unita, e in particolare la crescente popolarità di mafia e camorra considerate alla stregua di sette segrete, è strettamente legato alla lotta dello Stato contro gli eversori, repubblicani prima e socialisti internazionalisti poi. In questo dirompente e innovativo libro, Francesco Benigno illustra il rapporto tra il neonato Stato italiano e la criminalità organizzata, avvalendosi di fonti d'epoca poliziesche e giudiziarie oltre che delle fonti giornalistiche coeve. Il risultato dell'indagine mostra come attorno al nodo dell'ordine pubblico la società italiana si divida e si ricomponga lungo linee di frattura che oppongono - a Nord come a Sud - svariate opzioni ideali e politiche e differenti concezioni della pubblica sicurezza. Il libro mostra anche la genesi di pratiche poliziesche di manipolazione, infiltrazione e diversione comuni in epoca liberale e che, attraverso il fascismo, sono poi transitate nell'Italia repubblicana.
Lo sviluppo del crimine organizzato nei primi due decenni dell'Italia unita, e in particolare la crescente popolarità di mafia e camorra considerate alla stregua di sette segrete, è strettamente legato alla lotta dello Stato contro gli eversori, repubblicani prima e socialisti internazionalisti poi. In questo dirompente e innovativo libro, Francesco Benigno illustra il rapporto tra il neonato Stato italiano e la criminalità organizzata, avvalendosi di fonti d'epoca poliziesche e giudiziarie oltre che delle fonti giornalistiche coeve. Il risultato dell'indagine mostra come attorno al nodo dell'ordine pubblico la società italiana si divida e si ricomponga lungo linee di frattura che oppongono - a Nord come a Sud - svariate opzioni ideali e politiche e differenti concezioni della pubblica sicurezza. Il libro mostra anche la genesi di pratiche poliziesche di manipolazione, infiltrazione e diversione comuni in epoca liberale e che, attraverso il fascismo, sono poi transitate nell'Italia repubblicana.
